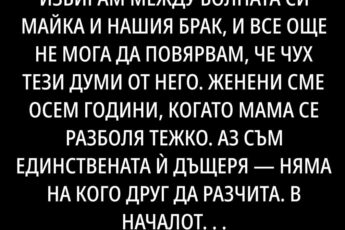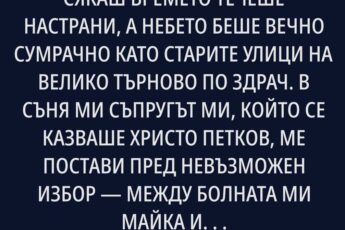Il mio nome è Carlo. Ho 72 anni. Vivo solo in una vecchia casa alla periferia di un paesino, dove un tempo tutto era pieno di vita. Qui, in questo cortile, mio figlio correva a piedi nudi nellerba, mi chiamava per costruire capanne con vecchie coperte, insieme arrostivamo patate nella brace e sognavamo il futuro. Allora, credevo che quella felicità sarebbe durata per sempre. Che ero necessario, importante. Ma la vita va avanti, e ora la casa è silenziosa. Polvere sul bollitore, uno scricchiolio in un angolo, e gli abbai occasionali del cane del vicino dietro la finestra.
Mio figlio si chiama Matteo. Sua madre, la mia defunta moglie Anna, ci ha lasciati quasi dieci anni fa. Dopo di lei, è rimasto lunico legame con un passato in cui cera ancora calore e significato.
Lo abbiamo cresciuto con amore e attenzione, ma anche con fermezza. Ho lavorato tanto, le mie mani non hanno mai conosciuto riposo. Anna era il cuore della nostra casa, e io, le sue braccia. Non cero sempre, ma quando serviva, ero presente. Schiavo del lavoro, ma padre a casa. Gli ho insegnato ad andare in bicicletta, ho riparato la sua prima Fiat 500, con cui è partito per studiare a Bologna. Ero orgoglioso di lui. Sempre.
Quando Matteo si è sposato, la mia gioia è stata immensa. La sua fidanzata, Giulia, mi è sembrata riservata, discreta. Si sono trasferiti allaltro capo della città. Ho pensato: pazienza, lascio che vivano la loro vita, che costruiscano qualcosa. E io sarò lì per aiutarli, sostenerli. Credevo che sarebbero venuti a trovarmi, che avrei potuto badare ai miei nipoti, leggere loro storie la sera. Ma nulla è andato come speravo.
Allinizio, solo telefonate brevi. Poi, solo messaggi per le feste. Sono andato da loro diverse volte con una crostata, dei dolci. Una volta mi hanno aperto, ma mi hanno detto che Giulia aveva lemicrania. Unaltra volta, il bambino dormiva. E la terza, non hanno nemmeno aperto. Dopo, ho smesso di andare.
Non ho fatto scenate. Non mi sono lamentato. Mi sono seduto e ho aspettato. Dicevo a me stesso: hanno i loro problemi, il lavoro, i bambini prima o poi si sistemerà. Ma il tempo è passato, e ho capito: non cè posto per me nella loro vita. Persino per lanniversario della morte di Anna, non sono venuti. Solo una telefonata e basta.
Recentemente, ho incontrato Matteo per caso in strada. Teneva suo figlio per mano, portava delle borse. Lho chiamato il cuore mi si è stretto di gioia. Si è girato, mi ha guardato come uno sconosciuto. «Papà, tutto bene?» ha chiesto. Ho annuito. Lui ha fatto lo stesso. Ha detto che era di fretta. Ed è andato via. Ecco il nostro incontro.
Ho camminato a lungo per tornare a casa. Mentre camminavo, mi chiedevo: dove ho sbagliato? Perché mio figlio mi è diventato estraneo? Forse sono stato troppo severo? O troppo permissivo? O forse sono diventato solo un peso con i miei ricordi, la mia vecchiaia, il mio silenzio
Ora, sono la mia famiglia, il mio sostegno. Preparo il tè, rileggo le lettere di Anna, a volte mi siedo sulla panchina e guardo i bambini degli altri giocare. La vicina, Lucia, ogni tanto mi saluta con la mano. Rispondo con un cenno del capo. È così che vivo.
Amo ancora mio figlio. Più di ogni cosa. Ma non aspetto più niente. Forse è il destino dei genitori lasciar andare. Ma nessuno ci prepara al giorno in cui diventiamo superflui nella vita di quelli per cui abbiamo vissuto.
E forse, questa è la vera maturità. Solo che non è più quella del figlio. Ma quella del padre.